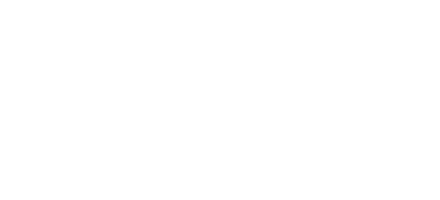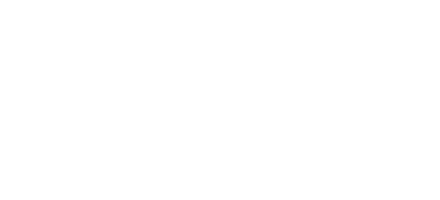A Venezia ci sono più di quattrocento ponti, ma non è sempre stato così. Per secoli, prima dell’arrivo dei vaporetti e molto prima che venissero costruiti gli attuali ponti sul Canal Grande, l’unico modo per attraversare la città era salire su una barca. Da questo gesto semplice nacque uno dei servizi più intelligenti e poetici della storia veneziana: i traghetti da parada.
Un tempo erano dodici, disseminati in punti strategici del Canal Grande e permettevano di passare rapidamente da una riva all’altra evitando lunghi giri tra calli e ponticelli. Erano una presenza quotidiana, quasi invisibile, parte della coreografia della città quanto l’acqua che la sostiene. Oggi ne resistono pochissimi, ma il loro fascino è rimasto intatto.
Immaginare Venezia com’era allora significa recuperare una forma di mobilità che appartiene al suo DNA. Quando i ponti erano pochi e il Canal Grande era un confine naturale, il traghetto era un gesto di normalità: si scendeva sulle rive, si chiamava il barcaiolo, si saliva a bordo e in pochi istanti ci si ritrovava dall’altra parte, pronti a cambiare sestiere e continuare la giornata.
Ripristinare, valorizzare o semplicemente raccontare questi tragitti significa riscoprire una Venezia diversa, fatta di passaggi rapidi, scorci inediti, nuovi modi di percorrere la città senza limitarsi ai soliti itinerari.
Dove tutto ebbe inizio
Furono i primi barcaioli veneziani a dar vita, inconsapevolmente, al concetto moderno di trasporto pubblico urbano.
Il traghetto, così si chiamava l’imbarcazione destinata a trasportare persone e merci lungo un percorso stabilito, era regolato da un sistema sorprendentemente avanzato. A gestirlo erano le Fraglie, corporazioni professionali organizzate in modo rigoroso, con statuti dettagliati, le Mariegole, che definivano norme, tariffe e responsabilità.
I traghetti si distinguevano in due categorie:
• i traghetti de dentro, attivi all’interno della città, suddivisi in traghetti da parada (per il semplice attraversamento) e traghetti da nolo (per trasferimenti più lunghi);
• i traghetti de fora, che collegavano Venezia all’entroterra trasportando persone e merci.
Alla caduta della Repubblica, nel 1797, esisteva ancora una rete fittissima di punti di attraversamento, ciascuno con una propria storia e un proprio gruppo di barcaioli.
La “barchéta”, non la gondola
Oggi chi passa per Venezia crede di vedere gondole ovunque, ma il traghetto da parada non è una gondola.
Non lo è nel gesto, nella funzione e nemmeno nella forma.
Il traghetto utilizza una barchéta, un’imbarcazione più tozza, stabile e capiente, nata da una tradizione diversa: barche da lavoro, usate un tempo anche per il trasporto di infermi, una sorta di ambulanza a remi. Quando questo servizio passò ai motoscafi, alcune barchéte rimasero in uso e dal 1953 sostituirono definitivamente le gondole nel ruolo di traghetto pubblico.
La barchéta può trasportare fino a 14 passeggeri, contro i sei di una gondola tradizionale, e si rema in piedi, senza fronzoli, con la naturalezza di chi vive l’acqua come una strada.
Una gondola… ma per davvero
Il traghetto da parada è un’esperienza profondamente veneziana. Nessuna scena stereotipata, nessuna serenata, nessun prezzo da souvenir.
Costa poco, 2 euro per i visitatori, 70 centesimi per i residenti, ed è un servizio pensato per chi vive la città ogni giorno.
Per molti veneziani, il traghetto è stato il primo contatto vero con la navigazione urbana: un’azione quotidiana, quasi automatica, che precede di anni l’idea di salire su una gondola “da giro”. Si attraversa il Canal Grande in piedi, affidandosi all’equilibrio, al gesto del barcaiolo, al ritmo dell’acqua. È un tragitto brevissimo, ma custodisce una familiarità rara: quella di una Venezia che non si guarda, ma si vive.
I traghetti ancora attivi
Oggi i traghetti da parada si trovano nei punti strategici del Canal Grande: San Tomà, Santa Sofia, Santa Maria del Giglio, Riva del Carbon, Punta della Dogana.
Il più frequentato è quello di San Tomà, che dimezza il tragitto tra San Marco e Piazzale Roma, ed è una vera ancora di salvezza per chi vuole evitare il Ponte di Rialto nelle ore più affollate.
Ma c’è un problema sempre più evidente: le code dei turisti, spesso lunghissime, rischiano di snaturare una tradizione pensata per i veneziani. Sensibilizzare i visitatori, spiegare loro che questo non è un servizio turistico ma un mezzo pubblico, è fondamentale per non perdere l’equilibrio delicatissimo tra vita locale e ospitalità.
Ca’ Marcello: vivere il tragitto da finestra
Tra i punti più affascinanti di questo andare e venire c’è proprio il traghetto di San Tomà. Accanto a questo storico punto di attraversamento si trova Ca’ Marcello, uno degli appartamenti che gestiamo con The Red House Company.
Le sue finestre si aprono sul continuo passaggio della barchéta: un fluire lento, quasi rituale, che scandisce la giornata come un battito regolare. Guardare il traghetto che parte, torna, si riempie e si svuota è ipnotico, una delle immagini più autentiche e intime di Venezia.
È un privilegio raro: non assistere alla Venezia dei turisti, ma a quella dei veneziani, degli studenti, dei lavoratori che ogni giorno attraversano il Canal Grande con naturalezza, come se fosse un marciapiede d’acqua.